
Antonio Carioti con il libro L’uomo che sfidò Mussolini. Giovanni Amendola antifascista liberale (Laterza) dedica una biografia al deputato vittima delle aggressioni squadriste di cui ricorre quest’anno il centenario della morte. Una figura che si distinse per la lucidità durante le prime fasi del Regime.
Giovanni Amendola nacque a Napoli nel 1882, figlio di un carabiniere originario di Sarno. Prima di diventare, come vedremo, una figura politica di rilievo, aveva, giovanissimo, conquistato una posizione nel panorama giornalistico e intellettuale scrivendo per il «Resto del Carlino», poi per il «Corriere della Sera» e per la prestigiosissima rivista di Giuseppe Prezzolini «La Voce». Ma — come mette ben in evidenza Antonio Carioti— la sua passione originaria, dalla quale non si sarebbe mai staccato del tutto, era stata la filosofia. E, benché cresciuto in un ambiente anticlericale, il suo, sempre secondo Carioti, fu uno spirito essenzialmente religioso. Il matrimonio con la tormentata ebrea lituana Eva Kühn diede alla figura intellettuale di Amendola un tocco aggiuntivo di originalità.
Il suo momento magico giunge all’indomani della Prima guerra mondiale (era stato, scrive Carioti, «interventista critico») quando la sua attività giornalistica si intreccia sempre più a quella politica. Nelle elezioni del 1919 viene eletto deputato per il partito Democrazia Liberale. Suo punto di riferimento è Francesco Saverio Nitti. Nel gennaio del 1921, il direttore del «Corriere» Luigi Albertini, già in dissenso con lui perché considera eccessive le sue aperture ai socialisti, «con estrema cortesia ma con altrettanta franchezza» (sottolinea Carioti) gli impone di scegliere tra impegno politico e attività giornalistica. Amendola sceglie il primo, anche perché ha già in progetto di fondare un proprio quotidiano, «Il Mondo» (che però vedrà la luce solo un anno dopo). Il 15 maggio del 1921 verrà rieletto deputato nelle ultime elezioni libere che si terranno in Italia prima della marcia su Roma. E nel 1922 sarà anche per un breve periodo (quello dei governi guidati da Luigi Facta) ministro delle Colonie.
Mussolini individuerà in Amendola un nemico. Già alla vigilia della marcia su Roma. E lui lo ricambierà della stessa moneta. Svolgendo un ruolo di primo piano dopo le elezioni del 1924 (in cui sarà eletto per la terza volta), a cui seguiranno il rapimento e l’uccisione di Giacomo Matteotti. Toccherà ad Amendola — come hanno ben documentato Claudia Baldoli e Luigi Petrella in Aventino: storia di un’opposizione al regime (Carocci) nonché Simona Colarizi in I democratici all’opposizione. Giovanni Amendola e l’unione nazionale 1922-1926 (il Mulino) — tessere la tela della secessione parlamentare, ribattezzata Aventino, che in qualche momento parve mettere in crisi il regime. Un tentativo velleitario e disperato? Non del tutto.
Una crepa grave per il fascismo e per il governo — ha notato Renzo De Felice in Mussolini il fascista. La conquista del potere 19211925 (Einaudi) — si aprì negli ambienti burocratici. Un po’ per «autonoma evoluzione», un po’ per l’azione della massoneria di Palazzo Giustiniani «scesa in campo con tutto il suo peso a fianco dell’opposizione» (mentre quella di piazza del Gesù continuava ad appoggiare il governo). Ma anche per il timore di venirsi a trovare troppo compromessa se il governo fosse caduto, «molta parte della burocrazia tendeva ad assumere un atteggiamento meno filofascista, più fermo verso certe manifestazioni del fascismo stesso e meno sordo a certe proteste dell’opposizione». E, sempre secondo De Felice, ancor più significativo fu ciò che avvenne tra i mutilati e i combattenti. I primi tennero il loro congresso a Fiume dal 7 al 10 luglio. I secondi ad Assisi dal 27 al 29 luglio. In entrambi i casi i rappresentanti del combattentismo non assunsero un atteggiamento di netta opposizione. Ma l’andamento dei due congressi «mostrò chiaramente come la politica mussoliniana andasse perdendo sensibilmente terreno tra di essi».
In autunno, poi, le cose per Mussolini si fecero ancora più complicate. Una tendenziale presa di distanza dal fascismo venne dal Partito liberale, scrive Guglielmo Salotti in Breve storia del fascismo. Dalla nascita dei Fasci di combattimento alla Repubblica Sociale Italiana (Bompiani). Il Partito liberale, riunito in congresso a Livorno dal 4 al 7 ottobre 1924, pur non passando all’opposizione, «non esaudì nemmeno le speranze di quanti in campo fascista puntavano a una sua scissione». L’ordine del giorno, approvato a netta maggioranza, conteneva un esplicito richiamo all’urgenza di «ristabilire, nella piena e assoluta efficienza, l’imperio della legge, base e condizione essenziale del libero svolgimento della vita di un popolo civile». Una conclusione, sottolinea Salotti, che fece infuriare Roberto Farinacci, il quale vedeva già i liberali «salire sull’Aventino a fianco dei comunisti e dei repubblicani per salvare la Costituzione». Quel cenno di Farinacci ai comunisti può essere considerato una svista. O, più probabilmente, la previsione, non infondata, che se gli aventiniani avessero avuto successo, i seguaci di Antonio Gramsci si sarebbero uniti ai secessionisti. Unica magra consolazione per il fascismo la circostanza che i ministri liberali fossero rimasti al loro posto e che la destra liberale, riconoscendosi nelle posizioni di Antonio Salandra, continuasse ad appoggiare il governo. Quel Salandra nei cui confronti Amendola ebbe sempre un’estrema diffidenza, come nota Carioti sulla base di un’attenta lettura delle lettere del protagonista della vicenda (Giovanni Amendola, Carteggio 1923-1924, Lacaita).
E siamo al punto centrale: le critiche che ancora oggi vengono rivolte all’Aventino. Il primo rilievo è che sarebbe stato forse più proficuo rimanere nell’aula parlamentare (come fecero i comunisti) e lì condurre una campagna assidua per inchiodare Mussolini alle sue responsabilità. Ma, sottolinea Carioti, la Camera nell’estate del 1924 era chiusa e sarebbe stata riaperta solo in novembre. Poi «ogni dibattito avrebbe fatto affiorare differenze politiche tra i variegati partiti dello schieramento aventiniano» offrendo ai fascisti l’opportunità di sfruttare queste divisioni a proprio vantaggio. Un’osservazione assai sensata. In Parlamento gli antifascisti si sarebbero mostrati impotenti e frantumati. E queste frantumazioni avrebbero offerto ai fascisti più bellicosi («pronti», scrive l’autore, «a trasformare Montecitorio in un ring di pugilato») l’opportunità di metterli ancor più di quanto già non lo fossero l’un contro l’altro.
La seconda critica è quella di aver riposto in Vittorio Emanuele III «una fiducia del tutto immeritata». Ma il re (come si sarebbe potuto constatare, 19 anni dopo, il 25 luglio del 1943) era l’unico soggetto dotato del potere di destituire il governo nel sistema disegnato dallo Statuto albertino. Mussolini disponeva infatti di una larga maggioranza sia alla Camera che al Senato. L’unica altra alternativa sarebbe stata quella insurrezionale prospettata dai comunisti i quali, però, erano i primi a essere consapevoli (in seguito lo ammetteranno esplicitamente) che la «rivoluzione» non avrebbe avuto la benché minima possibilità di successo dal momento che, parole di Gramsci, «per il capo del governo la piena disponibilità degli apparati di sicurezza non era mai venuta meno». Quel Gramsci, ricordiamolo, che ancora nel comitato centrale del partito tenuto in agosto, oltre ad affermare che l’avvento al potere del Duce aveva «solo ritardato la rivoluzione proletaria», aveva proclamato la «volontà di abbattere non solo il fascismo di Mussolini e Farinacci ma anche il semifascismo di Amendola, Sturzo, Turati». Cioè delle tre personalità che più efficacemente in quel dato momento avrebbero potuto operare per spodestare Mussolini. A cui andrebbe aggiunto Alcide De Gasperi, da poco segretario del Partito popolare italiano, che già a metà luglio aveva rigettato il criterio «dell’incompatibilità assoluta di una collaborazione parlamentare con i socialisti», prendendosi per questo una rampogna da parte dei gesuiti della «Civiltà Cattolica». La presa di posizione di Gramsci nel mese di agosto è uno dei non infrequenti abbagli dei comunisti in quell’epoca complicata.
Carioti considera giustamente che la svolta di Salerno effettuata nell’aprile del 1944 dal leader del Pci, Palmiro Togliatti — con la scelta di puntare sull’unità antifascista più vasta possibile (anche «a costo di entrare in un governo guidato da un ex uomo del regime, imputabile perfino di crimini di guerra, come Pietro Badoglio») — può apparire «un’autocritica implicita rispetto allo sterile atteggiamento di intransigenza rivoluzionaria mantenuto dai comunisti durante la vicenda dell’Aventino». Di più. Se «è innegabile che la strategia adottata da Amendola per sconfiggere Mussolini fallì e i suoi figli scelsero di proseguire la lotta in un partito ben distante dalle posizioni del padre, è anche vero che quello stesso partito, dovendo poi fare concretamente politica durante la Resistenza, seguì delle coordinate che, pur con degli obiettivi completamente diversi, non si discostavano molto dal richiamo prioritario all’unità antifascista del leader aventiniano».
In effetti la stagione che precedette il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 con il quale si aprì la stagione «totalitaria» già precedentemente individuata da Amendola — come nota Emilio Gentile in Storia del fascismo (Laterza) — quella stagione, dicevamo, andrebbe rivista con radicalità. Per dimostrare che l’Aventino fu un totale fallimento, bisognerebbe provare che c’era una alternativa praticabile. Si dovrebbe poter disporre di qualche prova (a oltre cento anni dai fatti) di una via attraverso la quale chi aveva preso le distanze da Mussolini fosse in grado di farlo cadere e avesse a disposizione, già pronta, una persona capace di prendere il suo posto. Si dovrebbe dimostrare che gli antifascisti avevano elaborato un disegno per superare d’un tratto le divisioni che li contrapponevano l’un l’altro. E fossero in grado, nel dicembre del 1924, di costringere il re ad esautorare Mussolini. Senza che lo stesso Vittorio Emanuele III corresse il rischio di essere esautorato a sua volta e sostituito con qualche membro della casa regnante. Il quale, rischiando la vita, avrebbe dovuto rendersi disponibile ad una sorta di colpo di Stato. Chi? Dove sono carte e documenti che attestano ci fosse anche una minima parte di queste condizioni?
Mussolini in quello scorcio di dicembre del 1924 capì che la situazione per lui si era fatta pericolosissima. Ma comprese anche che il re era troppo compromesso per tentare un’avventura in compagnia degli aventiniani. Già da tempo, d’altra parte, il sovrano aveva fatto i suoi calcoli e a quel punto non gli restava che subire lo sgradito discorso del 3 gennaio nonché la svolta autoritaria che ad esso si sarebbe accompagnata. L’Aventino aveva fatto traballare Mussolini, ma aveva anche messo a nudo l’impotenza di Vittorio Emanuele III. A Giovanni Amendola si deve dar atto di aver tenuto insieme per alcuni mesi gruppi recalcitranti, ognuno con in testa una propria soluzione, intossicati da personalismi e avversioni personalistiche. E di averli educati alla prospettiva dell’unità antifascista. Che risulterà sì praticabile, ma vent’anni dopo.
Il resto, per Amendola, è una storia di emarginazione politica, che, per parte fascista, si trasforma in persecuzione. Una seconda aggressione (dopo quella subita nel dicembre 1923) ne mina le condizioni di salute. Siamo nel luglio del 1925, Amendola è per la cura delle acque termali ai «Bagni» di Montecatini. L’assedio di un gruppo che lo ha in odio lo costringe ad allontanarsi dall’hotel La Pace. Apparentemente l’autorità locale lo aiuta a sottrarsi agli aggressori, ma quando la sua auto è nei pressi di Pieve a Nievole subisce un agguato. Poi si trasferirà in Francia e gradualmente scoprirà alcune inattese conseguenze di quell’aggressione. Nel febbraio (del 1926) i medici gli diagnosticheranno la degenerazione tumorale di un ematoma al polmone sinistro. Nel frattempo, l’amministratore del «Mondo» gli comunica d’essere stato costretto «a deliberare il suo licenziamento». Amendola capisce di essere alla fine dei suoi giorni (morirà a Cannes il 7 aprile). Poco prima — annota Carioti — ha chiamato al capezzale il figlio Giorgio, che, come il padre, è stato aggredito dai fascisti. E gli raccomanderà di «conquistarsi una forte posizione economica indipendente, prima di gettarsi nella politica». Ma il ragazzo non seguirà quel consiglio. Si iscriverà al Partito comunista, da lui considerato il più determinato a combattere il regime. Per diventarne, nel secondo dopoguerra, uno dei più autorevoli dirigenti. Forse il più autorevole per passione, complessità, cultura, capacità di tenere a battesimo un’intera generazione di dirigenti riformisti (tra cui Gorgio Napolitano). Frutto, tutto ciò, di una sofisticata elaborazione del lascito paterno.
Paolo Mieli Corriere della Sera 2 febbraio 2026
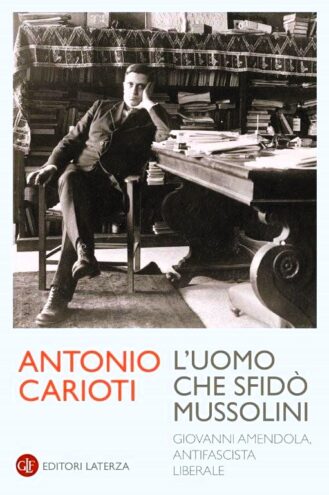


 GLI IDEALI DELLA SOCIETA’ SI DANNO ALLA MACCHIA
GLI IDEALI DELLA SOCIETA’ SI DANNO ALLA MACCHIA