
Tra il 1947 e il 1948 l’Oratorio fiorentino fu il rifugio di 70 esuli della Venezia Giulia che sfuggirono alla pulizia etnica del regime di Tito.
Per l’appassionato di arte barocca, come per il turista desideroso di evadere dai consueti itinerari, l’Oratorio dei Vanchetoni è una suggestiva testimonianza dell’arte e della pietà popolare nella Firenze del Seicento, tanto sobrio nella sua facciata quanto ricco al suo interno di eleganti testimonianze dell’arte barocca, oggetto negli ultimi anni di un accurato lavoro di restauro. L’aveva fatto costruire ai primi del XVII secolo il beato Ippolito Galantini, il figlio di un umile cardatore che consacrò tutta la vita alla catechesi. Era destinato a ospitare la Congregazione della Dottrina Cristiana, da lui fondata; ma i fiorentini la ribattezzarono dei Vanchetoni, dall’abitudine dei suoi membri di procedere silenziosi, «cheti», appunto, e il soprannome prese il sopravvento sul nome. Per alcuni mesi, però, fra il 1947 e il 1948, l’oratorio di via Palazzuolo è stato qualcosa di diverso da una raccolta di pregevoli testimonianze artistiche.
Fu il rifugio di 70 profughi della Venezia Giulia, costretti ad abbandonare la loro terra per sfuggire alla pulizia etnica del regime di Tito, agli orrori delle foibe, e persino, come a Pola, ad attentati terroristici.
Altri esuli giunti prima, dalla Grecia o dalle ex colonie, avevano trovato una sistemazione anch’essa precaria, ma almeno più confacente. I profughi erano arrivati per ultimi, perché sino all’ultimo, sino ai trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, molti di loro avevano sperato che la loro terra non passasse sotto il controllo jugoslavo. Si trovarono così a cercare accoglienza in una Firenze in cui il problema della casa era già drammatico.
Alcuni trovarono ospitalità fra le mura di Sant’Orsola o nell’ex caserma di via della Scala; ma la situazione era così critica che per altri l’unico rifugio fu l’Oratorio dei Vanchetoni con annessa cappella, ricca di testimonianze artistiche, ma inadeguata a fornire un’accoglienza salubre e dignitosa a famiglie alle prese con i problemi quotidiani dell’esistenza. Il presidente della Congregazione non fu felice della scelta, visto il valore dei beni conservati nella struttura, ma non poté certo opporsi alle pressioni del cardinale Elia Dalla Costa e di Giorgio La Pira. La sistemazione dei profughi si sarebbe dovuta limitare a poco più di un mese, ma in Italia — per dirla con Giulio Andreotti, che, come sottosegretario di Stato, fu chiamato in causa nella vicenda — non c’è nulla di più definitivo del provvisorio: la permanenza si protrasse per un anno, finché non fu trovato uno spazio più adeguato, in via della Pergola, nel complesso di Santa Maria Nuova.
La vicenda, a lungo rimossa dalla memoria, è stata riportata alla luce da Susanna Bino, figlia di due profughi istriani vissuti un intero anno nei locali della Congregazione. Il suo volume Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze: La vicenda dei Vanchetoni (1974-1948), edito dalla Aska, con i contributi di Stefano Cecconi, Gianni Silei ed Elio Varutti, è il frutto di un paziente lavoro di ricerca archivistica e bibliografica, cui l’autrice aggiunge un supplemento d’anima. Le memorie di legittime preoccupazioni e grette recriminazioni convivono nelle pagine di questo saggio. C’è l’opportunismo della stampa di sinistra, che prima tratta i profughi da «fascisti», poi protesta perché la sistemazione accordata loro in via della Pergola non è adeguata; ci sono le rimostranze del Presidente dell’Oratorio, che per fare impressione sul cardinale Elia Dalla Costa allude alla «condotta non troppo intransigente» degli «individui di sesso femminile» presenti fra i rifugiati (quanta eufemistica ipocrisia in quell’allusione!), accusa di «senso vandalico» le donne che cucinano sopra l’altare del Beato, enfatizza i danni riportati dalla struttura per una prolungata occupazione (ma non era colpa degli esuli se la Valdarno, che all’epoca gestiva la rete elettrica, aveva tagliato la corrente, incurante della loro drammatica situazione, costringendoli a riscaldarsi con mezzi di fortuna). E ci sono i ricordi del padre dell’autrice, Antonio, pubblicati in appendice che, per quanto scritti 65 anni dopo gli eventi, documentano con freschezza e franchezza tutto il dramma di una fanciullezza. C’è l’odio di parte della popolazione aizzata contro i profughi «fascisti», che induce il ragazzino quindicenne a rinunciare ai pasti della mensa popolare perché l’accento veneto tradisce la sua origine e lo espone a minacce e insulti; c’è persino il racconto di una scorribanda sotterranea che Antonio compie fra le ossa dei defunti, dopo aver scoperchiato una lapide; e non mancano le drammatiche notizie sugli infoibamenti ricevute da giovani profughi che in un primo tempo avevano collaborato con i partigiani slavi, «ma poi, come tutti, avevano preferito l’esilio al restare con quelli».
Enrico Nistri Corriere Fiorentino 7 febbraio 2026
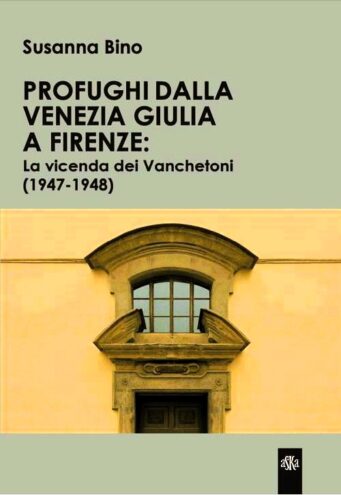


 COSI’ L’IDEA LIBERALE DIVENNE ANTIFASCISTA
COSI’ L’IDEA LIBERALE DIVENNE ANTIFASCISTA